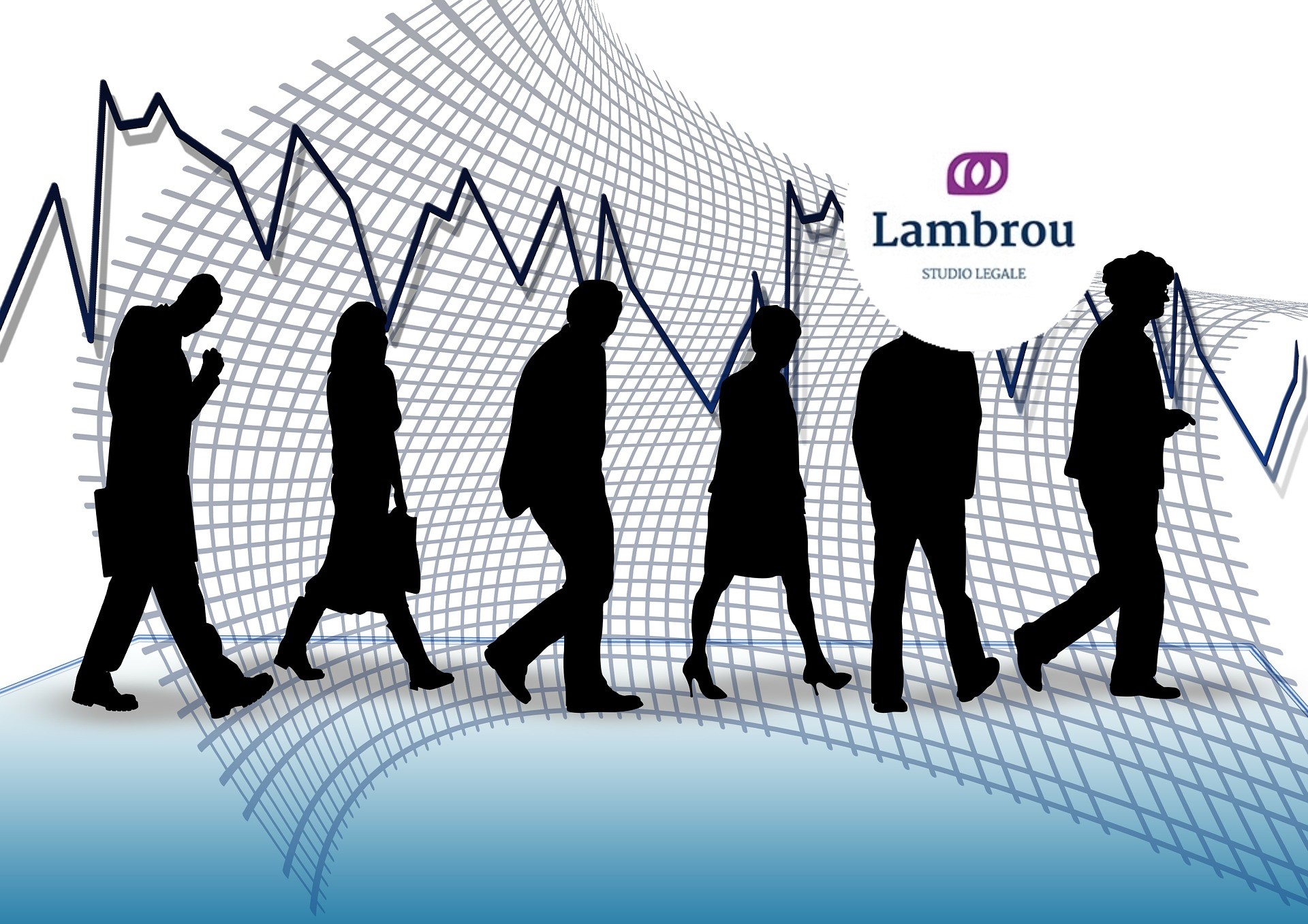Il licenziamento collettivo è l’esito della procedura avviata dall’impresa datrice di lavoro che, per una molteplicità di motivi, quali crisi, ristrutturazione, chiusura dell’attività imprenditoriale o di un ramo d’azienda, comporta una riduzione del personale dipendente. I presupposti dei licenziamenti collettivi sono individuati dalla legge in specifici casi ed è solo dopo la conclusione di un complesso procedimento, al quale prendono parte anche le rappresentanze sindacali, che il licenziamento diviene efficace. Il datore di lavoro, infatti, non è libero nella scelta dei lavoratori da licenziare: i criteri di predisposizione della lista dei dipendenti interessati sono indicati legislativamente, e obbligatori a pena di nullità della procedura. Sin dall’Accordo Interconfederale del 7 agosto 1947, la stessa nozione di licenziamento collettivo trovava il suo fondamento nell’esigenza di “riduzione o trasformazione di attività o di lavoro”; la ratio del licenziamento collettivo, in contraltare a quello individuale, infatti, si fonda sul potere di organizzazione imprenditoriale, naturale diramazione della libertà di iniziativa economica privata, tutelata all’art. 41 Cost.
Disciplina del recesso
Mentre la disciplina del recesso del datore di lavoro in materia di licenziamenti individuali si sviluppò, nel corso degli anni, attorno al “giustificato motivo” come limite a tale diritto potestativo, il fondamento della libertà organizzativa imprenditoriale prevalse inizialmente su possibili riforme improntate sulla conservazione del posto di lavoro. Per garantire tutela ai lavoratori, la giurisprudenza nel corso degli anni elaborò diversi principi e vincoli per la legittimità del licenziamento collettivo. Negli anni ‘80 le S.U. della Corte di Cassazione elevarono, a requisito formale essenziale, l’espletamento delle procedure di consultazione sindacale e proclamarono l’illegittimità del licenziamento collettivo non casualmente collegato ad una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, dando una lettura orientata a distinguere il ridimensionamento strutturale dell’azienda dal calo di attività produttiva. La riduzione dell’attività aziendale, perché potesse essere motivo di legittimo licenziamento collettivo, venne modellata sull’irreversibilità del trend passivo dell’impresa: furono dichiarati illegittimi, per carenza di motivazione, i licenziamenti collettivi nei casi di diminuzione transitoria della produzione. La disciplina del licenziamento collettivo trova il suo ancoraggio normativo nella legge 23 luglio n. 223/1991, nella quale venne trasposta la precedente disciplina e gli approdi giurisprudenziali, oltre che l’attuazione della Direttiva 129/1975/Cee. La normativa venne integrata e modificata dal D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 151, emanato in attuazione della Direttiva 56/1992/Cee, e dal D.Lgs. 8 aprile 2004 n. 110, con il quale si è esteso l’ambito di applicazione dei licenziamenti collettivi ai datori di lavoro non imprenditori; l’ultima modifica è avvenuta con il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, che ha inciso sulla tutela a seguito dell’illegittimità del licenziamento. La disciplina, oggi, racchiude tutti i casi di eccedenza del personale. Si distinguono due fattispecie di portata generale a seconda del momento in cui l’eccedenza del personale si manifesti: qualora essa sopravvenga in un momento di crisi d’impresa, per la quale sia intervenuta la Cgis, essa viene definita “collocamento in mobilità”;l ’altra ipotesi, definita come “licenziamento collettivo per riduzione di personale”, rientra nei casi in cui l’impresa si trovi di fronte ad un momento di riduzione, trasformazione o cessazione dell’attività di lavoro.
Normativa di riferimento e procedura
La legge n. 223/1991 e le successive modifiche, prevedono due diverse ipotesi di licenziamento collettivo che si distinguono per i presupposti fattuali alla base. La prima ipotesi, il licenziamento collettivo al fine di ridurre il personale, è quella prevista dall’art. 24 della legge n. 223/1991 e riguarda tutti i datori di lavoro privati, imprenditori e non, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) numero complessivo di dipendenti superiore a 15;
b) l’intenzione di effettuare almeno 5 licenziamenti in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive, nell’ambito del territorio di una stessa provincia, nell’arco di 120 giorni dalla conclusione della procedura, salvo che un diverso termine sia stato previsto con accordo sindacale;
c) si trovino in una situazione di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o intendano cessare l’attività.
I requisiti di cui sopra devono tutti sussistere al momento dell’avvio della procedura e non anche nella fase conclusiva di essa, potendo gli accordi sindacali incidere sul numero dei dipendenti da licenziare, come sull’arco temporale in cui porre in essere il licenziamento. Il numero dei dipendenti va calcolato sulla media di dipendenti nel semestre precedente l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. In ogni caso la procedura può concludersi anche con un numero di licenziamenti inferiore a 5, a condizione che, al momento dell’avvio della procedura, il datore di lavoro abbia comunicato l’intenzione di licenziare almeno 5 dipendenti. Il collocamento in mobilità, invece, è previsto dall’art. 4, comma 1, legge n. 223/1991 e riguarda solo i datori di lavoro privati imprenditori che rientrano nella disciplina dell’intervento della Cigs e che, una volta ammessi al trattamento, ritengano di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative. In questa ipotesi non sono richiesti i requisiti dimensionali e numerici, previsti dall’art. 24, comma 1, legge n. 223, e specificati ai suindicati punti a)eb). In entrambe le due ipotesi di licenziamento collettivo la procedura da attivare è la stessa ed è disciplinata dall’art. 4, commi da 2 a 12, assieme all’art. 5 e all’art. 24.
In primo luogo, si svolge una fase di consultazione tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, essendo, l’impresa procedente, obbligata ad informare le rappresentanze sindacali presenti in azienda e i Sindacati maggiormente rappresentativi. A seconda della rilevanza del licenziamento, poi, attraverso la comunicazione, l’impresa dovrà informare rispettivamente l’organo competente territorialmente. Sul datore di lavoro ricade l’onere di illustrare quali sono i motivi alla base della decisione del licenziamento, e giustificare l’impossibilità di utilizzare strumenti diversi da quelli del licenziamento. Nella comunicazione devono essere individuati il numero dei lavoratori, i tempi di attuazione della procedura, le misure per limitare l’impatto sociale del licenziamento sui lavoratori. L’importanza della comunicazione è stata ribadita dalla stessa giurisprudenza che ha confermato che: “l’incompletezza di contenuto della comunicazione di avvio della procedura di mobilità invalida la procedura e determina l’inefficacia dei licenziamenti, nonostante la stipulazione di un accordo sindacale di riduzione del personale che contempli un criterio di scelta dei lavoratori da licenziare” (Cass. n. 5034/2009).
In questa fase, i sindacati hanno la facoltà di richiedere un esame congiunto della pratica entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine di raggiungere un accordo modificativo o alternativo. Il periodo di consultazione ha un termine massimo di 45 giorni, esaurito il quale, se non dovesse essere raggiunto alcun accordo, l’impresa ha l’obbligo di comunicare per iscritto all’organo territoriale le motivazioni sottostanti il fallimento delle trattative.
In caso di mancato accordo, vi può essere la possibilità di una seconda convocazione ai fini conciliativi. Esaurita tale fase il datore di lavoro può intimare il licenziamento ai lavoratori in esubero, secondo i criteri previsti dall’art. 5, legge n. 223/1991, di cui si parlerà più approfonditamente in seguito. L’importanza dei sindacati nella procedura è confermato dalla stessa giurisprudenza, che ha chiarito anche il relativo ruolo rispetto alla materia dei licenziamenti collettivi: il controllo giurisdizionale viene esercitato ex post rispetto al controllo dell’iniziativa imprenditoriale concernente il ridimensionamento dell’impresa, devoluto ex ante alle organizzazioni sindacali.
Infine, i lavoratori licenziati collettivamente vengono inseriti nelle c.d. liste di mobilità che permettono ai lavoratori sia di usufruire di un’agevolazione al ricollocamento in un ruolo adeguato alla loro professionalità, sia il diritto ad una speciale indennità di disoccupazione (c.d. indennità di mobilità) in attesa della nuova occupazione.
Criteri di applicazione del licenziamento
Esaurita la procedura di cui sopra, l’imprenditore può procedere al “recesso” dal rapporto, come definito all’art. 4, comma 9, legge n. 223/1991. Come si è detto, il rispetto dei requisiti procedurali da espletare, da parte del datore di lavoro, sono posti dalla legge a pena di invalidità del licenziamento e i criteri di scelta si devono basare su criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, derogabili solo in presenza di un accordo sindacale che disciplini il programma di riduzione del personale. Qualora i contratti collettivi, nello specifico, non dovessero prevedere i criteri di selezione del personale da licenziare, sarà la legge n. 223/1991 a integrarne i limiti; la norma stabilisce 3 criteri generali da rispettare nella scelta e da applicare congiuntamente. L’art. 5, comma 1, indica:
a) i carichi di famiglia, la presenza di un coniuge e/o figli a carico del lavoratore selezionato;
b) l’anzianità del lavoratore, in considerazione del fatto che un lavoratore più anziano ha più difficoltà a reinserirsi nel mondo del lavoro rispetto ad uno giovane;
c) le esigenze tecniche, produttive e organizzative dell’impresa, elevate a criterio logico-funzionale, dalla giurisprudenza, nella valutazione della legittimità del licenziamento.
L’applicazione di tali criteri da parte del datore di lavoro, comunque, viene valutata sulla base dei principi generali dibuona fede e correttezza, come delineato dalla Cassazione nella sentenza n. 17556/2004. Eventuali accordi tra imprese e sindacati, in deroga ai criteri ex art. 5l, legge n. 223/1991, devono rispettare due principi di carattere generale: quello di non discriminazione (licenziamenti non basati su motivazioni sindacali, religiose, politiche, ecc.) e quello di razionalità (la presenza di un nesso causale tra le esigenze aziendali e il licenziamento da porre in essere). Il contenuto del principio di razionalità è stato specificato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 268/1994, che ha sancito che i criteri concordati debbano avere “i caratteri dell’obbiettività e della generalità e devono essere coerenti col fine dell’istituto della mobilità dei lavoratori”. Ulteriori limiti insuperabili, nella scelta del personale da licenziare sono previsti legislativamente, e specificati dalla giurisprudenza, per alcune categorie di lavoratori. Ad esempio, nel licenziamento collettivo il numero di invalidi coinvolti, rispetto al totale di lavoratori licenziati, non potrà essere superiore alla percentuale prevista dalla norma in tema di assunzioni obbligatorie. Infatti, l’articolo 10, legge n. 68/1999 prevede che i licenziamenti collettivi promossi nei confronti del lavoratore disabile assunto obbligatoriamente, potrebbero essere annullabili qualora il numero dei rimanenti lavoratori assunti ai sensi della norma sopra citata, appunto, sia inferiore alla quota d’obbligo di cui all’articolo 3, legge n. 68/1999.
Carichi di famiglia: norma e interpretazione giurisprudenziale
Il criterio dei “carichi di famiglia” emerge per il fatto che, a parità di altre condizioni, si dovrebbe licenziare chi ha un minor numero di familiari a carico rispetto ad un lavoratore che ne ha di più. Tale criterio, oltre a fondarsi sul dato fattuale che un lavoratore con meno figli a carico sia maggiormente in grado di far fronte alla perdita del posto di lavoro, risponde ad un più alto principio di tutela del nucleo famigliare ex art. 29 Cost. Il significato di “carico di famiglia”, di cui all ’art. 5, legge n. 233/1991, è stato oggetto di un’interpretazione estensiva da parte della giurisprudenza. Partendo dal presupposto che la normativa tende a limitare le conseguenze sociali del licenziamento collettivo in riferimento a lavoratori con situazioni economiche più deboli, i “carichi di famiglia” sono stati interpretati dalla giurisprudenza come sintomo di debolezza sociale ed economica dell’individuo scelto nel licenziamento. Sulla stessa linea, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20464/2018, ha statuito che i carichi di famiglia vadano interpretati estensivamente ed essere riscontrati fattualmente, non essendo sufficiente l’accertamento documentale e fiscale da parte del datore di lavoro. Il caso in esame, in particolare, vedeva coinvolto un datore di lavoro che, nell’applicare il criterio di scelta dei carichi di famiglia, si era basato sui dati risultanti dalle dichiarazioni Irpef per procedere al licenziamento di una lavoratrice, che aveva figli a carico, non risultanti dalle sue dichiarazioni dei redditi. La società partendo dal solo dato fiscale, procedeva con il licenziare la lavoratrice, anche se avrebbe potuto presumere la situazione denunciata sulla base dei permessi per maternità concessi alla lavoratrice.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso sopra citato, ha definitivamente dichiarato l’illegittimità della condotta aziendale, e conseguentemente del licenziamento della lavoratrice, statuendo che la corretta applicazione del criterio dei carichi di famiglia impone di considerare la situazione familiare effettiva dei singoli lavoratori e “non può limitarsi alla semplice verifica del numero delle persone a carico da un punto di vista fiscale, che potrebbe risultare anche riduttiva”. È stato, dunque, giudicato che: “è onere del datore di lavoro che sia a conoscenza in modo ufficiale della reale situazione economica familiare del dipendente, tener conto di quest’ultima anche a prescindere da una espressa comunicazione ad hoc del lavoratore”.
Se l’azienda avesse tenuto conto dei reali carichi di famiglia della lavoratrice, e non solo dei dati emergenti dalla dichiarazione dei redditi, quest’ultima non sarebbe stata licenziata. Sebbene il parametro della dichiarazione Irpef non costituisse un dato sufficiente per misurare il criterio dei carichi familiari, l’interpretazione della Corte non onera il datore di lavoro dell’obbligo di condurre indagini approfondite su ogni singolo lavoratore, che potrebbero risultare invadenti e lesive della privacy di quest’ultimo, ma di agire secondo buona fede e correttezza.
Anzianità, criterio di selezione legale e prossimità all’età pensionabile, come criterio fattuale
L’anzianità del lavoratore, come parametro legislativo summenzionato, che a parità di requisiti dovrebbe portare a considerare il licenziamento di un lavoratore più giovane, per la facilità di quest’ultimo a reinserirsi nel mondo del lavoro, trova un limite nella prassi degli accordi collettivi. Esso, infatti, viene bilanciato dal criterio della prossimità della pensione, per il quale in assenza di ulteriori elementi distintivi, andrebbe preferito nella selezione il lavoratore più vicino all’età pensionabile. La prossimità alla pensione è sempre stato uno dei criteri più utilizzati in sede di contrattazione collettiva ed è stato recentemente riconfermato dalla giurisprudenza. La finalità di riduzione del costo del lavoro, ridimensionando l’organico, ha giustificato la selezione dei lavoratori in base al criterio di pensionabilità, sul principio del minor impatto sociale al quale dovrebbe aspirare, idealmente, il licenziamento collettivo. Il nucleo centrale di questo criterio selettivo è la possibilità di sostituire il reddito da lavoro con il trattamento pensionistico (Cass. n. 4186/2013). Rispetto alla possibilità che tale criterio potesse risultare discriminatorio, in tutti i casi in cui i lavoratori vicini alla pensione rappresentino una percentuale più alta rispetto ai dipendenti da licenziare, la giurisprudenza ha elevato a requisito di legittimità l’inserimento di un ulteriore criterio di selezione interna. In particolare, il raggiungimento dell’età pensionabile, come criterio, va ancorato a ragioni di riorganizzazione aziendale e, in ogni caso, deve essere applicato in modo tale da non lasciare spazio alla discrezionalità del datore di lavoro nella scelta dei dipendenti da licenziare (Cass 22 giugno 2012, n. 10424).
Alta specializzazione del lavoratore
Come si è già delineato, gli accordi sindacali potrebbero prevedere criteri diversi da quelli previsti legislativamente, nella selezione del personale coinvolto nella procedura dei licenziamenti collettivi. I principi da rispettare permangono quelli di non discriminazione e razionalità, vagliati anche sulla motivazione addotta nel licenziamento. Uno di questi criteri può essere la specializzazione del lavoratore in rapporto al settore in cui opera l’azienda. Tale criterio ha avuto diverse declinazioni giurisprudenziali, che hanno interessato il più ampio ambito delle esigenze produttive aziendali e la fungibilità della prestazione lavorativa in altre mansioni aziendali. Molte di queste pronunce hanno avuto ad oggetto la chiusura di un ramo aziendale o di un settore della società, e il conseguente impossibile reimpiego dei lavoratori licenziati collettivamente. Il requisito della professionalità è stato meglio espresso dalla Cassazione nella sentenza del 5 settembre 2018, n. 21670, con motivazione di questo tenore: “non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto lavorativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”. Egualmente è stato enunciato il principio di diritto per il quale: “qualora un’azienda debba ridurre il personale a seguito di chiusura di un reparto o di un’unità produttiva, la scelta dei dipendenti da porre in mobilità non può essere limitata ai soli addetti al reparto o all’unità da sopprimere, ma va necessariamente estesa a tutti i lavoratori con professionalità fungibili” (Cass. 9 novembre 2016, n. 22788). Il criterio della fungibilità della prestazione viene anche ad essere utilizzato quale principio di reimpiego del lavoratore: qualora si proceda ad un licenziamento settorializzato o di reparto, sul datore di lavoro permane l’onere di provare le motivazioni rispetto alle professionalità scelte e l’incompatibilità tra i dipendenti oggetto di licenziamento e i colleghi esclusi da esso (cfr. Cass. 7 dicembre 2018, n. 3175). Particolare attenzione è stata data, nella fase di accertamento del nesso causale tra il licenziamento collettivo e le esigenze aziendali, ai profili di professionalità, da valutarsi come più o meno utili rispetto all’attività d’impresa. Specificazione di tale criterio è rappresentato dall’alta specializzazione del lavoratore: esso attiene alla coincidenza del profilo professionale del lavoratore con il settore in cui opera l’impresa. Da ultimo la giurisprudenza della Suprema Corte, nella sent. n. 31872/2018, ha ribadito che il “criterio di selezione dell’alta specializzazione risulta dunque più funzionale, rispetto ai criteri di legge (anzianità di servizio e carichi familiari) eventualmente derogati dall’accordo sindacale, per scongiurare la cessazione dell’attività e, quindi, per tutelare l’occupazione, poiché consente la prosecuzione dell’attività aziendale con un impatto minimo sui livelli occupazionali dell’impresa”. In questo caso il principio dell’alta specializzazione è stato considerato legittimo perché il ricorso ai menzionati criteri di legge risultava essere del tutto insufficiente allo scopo di salvaguardare la prosecuzione dell’attività produttiva.
Considerazioni conclusive
Infine, merita menzione la scelta volontaria di porsi in mobilità. Molto spesso, nell’ambito di una procedura di licenziamento, la scelta di porsi in mobilità viene usata come primo criterio di selezione, potendo gli stessi lavoratori aderirvi. La spontanea adesione trova molto spazio negli accordi sindacali e nei casi di accompagnamento dei lavoratori alla pensione. Rispetto ai criteri summenzionati occorre sottolineare che la giurisprudenza, al fine di limitare l’abuso del licenziamento collettivo, tende a concentrarsi sui riscontri fattuali dei criteri scelti dal datore di lavoro, per il quale l’obbligo di motivazione diviene sempre più incisivo. La sussistenza del nesso logico-funzionale tra crisi aziendale e i criteri di scelta, oggi deve risultare ictu oculi, e va giustificata tanto al principio del licenziamento, nella comunicazione, quanto nella fase esecutiva di esso.
CONTRIBUTO PUBBLICATO SU DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO DI IPSOA