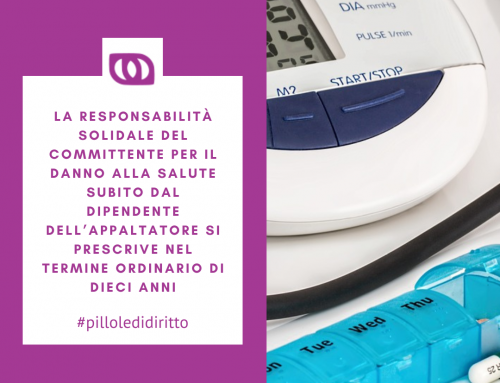E’ legittimo denunciare il proprio datore di lavoro? L’archiviazione del procedimento penale è idonea ad integrare la giusta causa del licenziamento? Quale può essere la reale portata da attribuire all’obbligo di fedeltà del lavoratore?
A questi interrogativi la Corte di Cassazione ha tentato di dare risposta con la sentenza n. 22375 del 26 settembre 2017, per mezzo della quale ha dichiarato l’illegittimità del licenziamento comminato ad una dipendente che aveva querelato il proprio titolare.
Nel caso di specie, la donna provvedeva a denunciare lesioni personali e maltrattamenti subiti, a suo dire, a causa della condotta vessatoria di cui si era reso protagonista, in costanza di rapporto di lavoro, il legale rappresentante della società. In sede penale il procedimento si concludeva con l’archiviazione e alla lavoratrice veniva intimato licenziamento per giusta causa, alla luce della presunta irreparabile lesione del dovere di fedeltà nel corretto svolgimento del rapporto lavorativo che non avrebbe reso possibile l’irrogazione di sanzioni conservative. Il giudice di primo grado, nel dichiararne l’illegittimità, disponeva la reintegrazione con conseguente pagamento delle mensilità arretrare, ma, riformando la sentenza, la Corte d’appello di Bologna riconosceva la liceità del provvedimento espulsivo ritenendo necessaria la sussistenza, con riferimento alla denuncia, dei principi di continenza formale e sostanziale. Di tali presupposti l’azione della dipendente sarebbe stata carente, essendosi dimostrati privi di rilievo sotto il profilo penalistico i fatti dalla stessa riportati e sarebbe risultata irrilevante ai fini della decisione l’assenza di reali pregiudizi all’immagine della società.
Investita della questione, la Suprema Corte ha perentoriamente affermato come la presenza e la valorizzazione degli interessi pubblici superiori sia idonea ad escludere che “nell’ambito del rapporto di lavoro la sola denuncia all’autorità giudiziaria di fatti astrattamente integranti ipotesi di reato, possa essere fonte di responsabilità disciplinare e giustificare il licenziamento per giusta causa”. Non sarebbe, infatti, possibile infirmare, in qualche modo, il valore civico e sociale che in uno Stato di diritto caratterizza l’iniziativa del privato atta a sollecitare l’intervento dell’autorità giudiziaria per la repressione di fatti illeciti.
Il recesso potrebbe definirsi legittimo qualora si dimostrasse il carattere calunnioso della segnalazione, ossia la consapevolezza da parte del lavoratore della non veridicità della condotta denunciata e, al tempo stesso, la volontà di accusare il responsabile per i fatti non commessi. Più precisamente, la responsabilità disciplinare sorge allorquando il ricorso ai pubblici poteri avvenga “in maniera strumentale e distorta” e non può, in questo senso, risultare sufficiente “che la denuncia si riveli infondata e che il procedimento penale venga definito con la archiviazione della ‘notitia criminis’”. Sarebbe, in ogni caso, parimenti illegittima, nonché potenzialmente idonea ad arrecare un danno all’immagine dell’imprenditore, la condotta del dipendente che compiesse azioni finalizzate a dare pubblicità alla propria querela.
Quanto all’obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. (in forza del quale è precluso al prestatore di lavoro di “trattare affari in concorrenza con l’imprenditore” e di “divulgare notizie attinenti all’organizzazione dell’impresa o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”), il giudice di legittimità ha chiarito come la portata della norma non possa estendersi, quand’anche interpretata in relazione ai generali doveri di correttezza e buona fede, sino alla negazione della possibilità di denunciare fatti illeciti consumati in azienda.
La pronuncia in oggetto si pone decisamente in continuità con l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato sul tema. Invero, in più occasioni la Suprema Corte aveva avuto modo di affermare come né il licenziamento per giusta causa, né per giustificato motivo oggettivo, potessero ritenersi privi di censure se mossi con l’obiettivo di sanzionare “il legittimo esercizio di un diritto, coperto dall’efficacia scriminante dell’art. 51 c.p., di portata generale nell’ordinamento e non già limitata al mero ambito penalistico” (si legga, in questo senso, Cassazione, sentenza n. 14249 del 8 luglio 2015). Dall’interpretazione estensiva dell’art. 51 c.p. ad ambiti ulteriori rispetto al penale e, nel caso di specie, al contratto di lavoro, discende la non antigiuridicità del comportamento del dipendente. L’”esercizio di un diritto” ex art. 51, consistente nella fattispecie in esame nella denuncia all’autorità, risulta infatti idoneo ad elidere l’applicazione rigorosa dell’ art. 2105 c.c., attenuando il dovere di fedeltà e “scriminando” l’agente (nella fattispecie il lavoratore) dall’eventuale violazione.
Occorre rilevare una certa opportunità dell’impianto argomentativo della Corte, in particolar modo in considerazione del rischio, paventato dallo stesso giudice, che l’obbligo di fedeltà gravante sul prestatore possa tramutarsi nel riconoscimento implicito di una sorta di “dovere di omertà” in capo allo stesso.