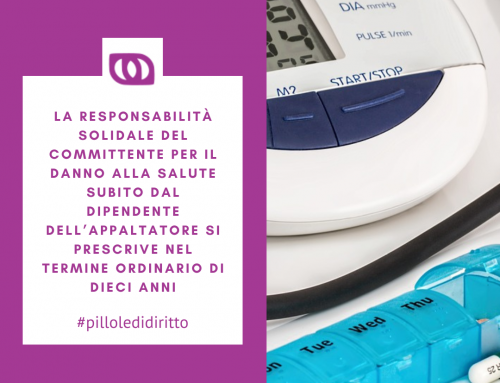Chiamata a pronunciarsi con riferimento alla portata del dovere di vigilanza del collegio sindacale nell’ambito delle società di capitali ex art. 2407 comma 2 del Codice civile (ai sensi del quale gli stessi sono “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”) la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 21566 del 18 settembre 2017, ha contribuito a offrire elementi utili per la corretta individuazione dei comportamenti idonei a costituirne una violazione.
In particolare, sarebbe imputabile ai sindaci la mancata rilevazione di una macroscopica violazione ad opera degli amministratori, ovvero la totale inerzia di fronte ad atti di dubbia legittimità posti in essere dai medesimi. Il compito di vigilanza cui questi sono chiamati, infatti, comprende la valutazione circa la ragionevolezza economica delle scelte gestionali, tanto da indurre taluno a definirlo come un vero e proprio “controllo di legittimità sostanziale”. Più precisamente, tra gli obblighi legati alla natura della funzione rientrerebbe quello di vigilare sul rispetto delle norme statutarie e legislative che disciplinano il funzionamento degli organi societari, dei principi di corretta amministrazione, delle disposizioni atte a regolare lo specifico settore di attività nel quale l’impresa opera, nonché sulla conformità di eventuali deliberazioni degli organi societari alla legge e allo statuto. Nel caso esaminato dalla sentenza della Suprema Corte di cui sopra, si registrava un’omissione di qualsivoglia intervento atto a segnalare lo stato di dissesto in cui versava la società, nonché l’inopportuna sollecitazione all’approvazione dei bilanci alla luce delle rassicurazioni degli amministratori.
A ben vedere, già con la sentenza n. 22911 dell’11 dicembre 2010, la Corte aveva avuto modo di chiarire come non si renda necessaria, ai fini della configurabilità di una forma di responsabilità, l’individuazione di specifici comportamenti passibili di censure, quanto più la mera inoperosità nella ricerca di rimedi e nella denuncia delle violazioni. Si tratta di una responsabilità di natura contrattuale (allorquando l’azione sia esercitata dalla società stessa o dai soci di minoranza), poiché i doveri funzionali che legano i sindaci alla società rientrano nell’adempimento del contratto sociale, con liberazione degli stessi nel caso in cui, pur senza scongiurare concretamente la manifestazione del danno, abbiano realmente assolto la propria funzione di vigilanza, ovvero dimostrino come, attraverso le ordinarie operazioni di controllo, gli errori di gestione non fossero riscontrabili.
Invero, va rilevato come il collegio sindacale sia chiamato all’adempimento di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, non potendo imputarsi allo stesso la circostanza di non aver evitato il dissesto. A venire in rilievo è, dunque, il criterio della diligenza che, come chiarito – ancora una volta – dalla Corte di Cassazione, può fungere da adeguato parametro per “determinare, anche sotto il profilo oggettivo, l’area del comportamento dovuto”, nell’ambito di una prestazione ad alto grado di discrezionalità tecnica (Cassazione, sentenza n. 2538 del 8 febbraio 2005). Non si tratta della diligenza del buon padre di famiglia, bensì di una diligenza qualificata da “valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata” (Art. 1176 del Codice civile). A livello probatorio, l’onere di dimostrare il comportamento negligente grava sul creditore della prestazione, conseguendone, ai fini del corretto esperimento di un’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci, la necessità di provare, oltre alla violazione dei relativi doveri d’ufficio, come il danno arrecato alla società ne costituisca una diretta conseguenza. A tal riguardo può notarsi come, nella difficoltà di fornire prova idonea del nesso causale tra evento dannoso e mancato intervento finalizzato a scongiurarlo, una prassi giurisprudenziale consolidata adotti il criterio dell’ id quod plerumque accidit, in virtù del quale si fa riferimento a ciò che normalmente accade in conseguenza di un determinato fatto e, nella specifica ipotesi del collegio sindacale, l’applicazione del principio comporta che il giudice sia chiamato a valutare se, sulla base delle aspettative razionali, in presenza di un comportamento diligente da parte del soggetto il danno si sarebbe comunque verificato.
Nonostante i componenti del collegio sindacale vengano chiamati a rispondere principalmente alla luce di un fatto, commissivo od omissivo, il cui autore, ossia l’amministratore, sia diverso, si configura in ogni caso una forma di responsabilità propria, legata al mancato esperimento delle misure idonee a caratterizzare l’attività di controllo come richiesta dalla legge, e non una responsabilità per fatto altrui. Sussiste, tra le due figure societarie, una particolare forma di solidarietà, per cui il sindaco risulta responsabile a livello civilistico se non rileva con culpa in vigilando l’inadempimento dell’amministratore. In questo senso, occorre sottolineare come l’interpretazione di tale responsabilità “concorrente” adottata dalla giurisprudenza nei riguardi dell’organo di controllo sia piuttosto severa e caratterizzata da un notevole utilizzo di presunzioni, tanto da condurre parte dei commentatori alla definizione di “responsabilità da posizione”.
L’adozione del criterio della diligenza risulta maggiormente pregnante se riferita alla carica di amministratore. Dall’assunzione di tale qualifica, infatti, discende l’onere di assolvimento delle proprie funzioni nel rispetto dell’atto costitutivo e, soprattutto, di compiere azioni con un rigore ed una diligenza commisurate alla natura dell’incarico assunto che, in considerazione del rilievo da doversi attribuire allo stesso, rende necessario un adempimento adatto a corrispondere all’alto grado di qualificazione professionale. La valutazione di tale natura deve per di più riferirsi al modello, alle dimensioni e all’oggetto della società, anche alla luce dell’eventuale specifico ruolo assunto all’interno del Cda.
Se non crea particolari problemi interpretativi la configurazione di una responsabilità (civile), così come l’esperimento delle relative azioni, in società a socio unico, essendo questi necessariamente da considerare come unico responsabile, maggiori riflessioni meritano di essere condotte con riferimento alla presenza di una pluralità di amministratori, riuniti collegialmente in un consiglio d’amministrazione. Nell’ipotesi considerata, limitandosi in questa sede al caso delle società per azioni, qualora i danni siano imputabili ad una delibera dell’organo amministrativo, deve ritenersi chiamata a rispondere la totalità dei componenti, fatta eccezione per l’eventuale amministratore dissenziente che non abbia concorso all’assunzione della decisione. Affinché tale dissenso possa ritenersi idoneo a “liberare” il soggetto in questione necessita di una particolare qualificazione: in particolare, è prescritta, ai sensi dell’art. 2392 del Codice civile, l’annotazione dello stesso “senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio”, oltre all’immediata comunicazione “per iscritto al presidente del collegio sindacale”.
A ben vedere, dalla lettura della medesima norma emerge come il membro del consiglio debba anche essere “immune da colpa”. La valutazione circa la portata da attribuire alla formulazione codicistica ha condotto, peraltro, ad interpretazioni dottrinali discordanti. In questo senso, abbracciando la tesi maggiormente accreditata tra i commentatori, ai fini della configurabilità dell’immunità risulta necessario che, unitamente all’espressa comunicazione di dissenso nelle forme precedentemente richiamate, il comportamento dell’amministratore non abbia nociuto in qualche modo alla società.
Qualora il danno arrecato sia imputabile non tanto all’amministratore quanto più al comitato esecutivo o ad altro amministratore con funzioni specifiche, il primo sarà in ogni caso chiamato a rispondere se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non abbia tenuto una condotta atta ad eliminarlo ovvero attenuarne le conseguenze.
Con la riforma del diritto societario del 2003 (D.lgs 6/2003) il legislatore è intervenuto a ridisciplinare, con innovazioni di carattere sostanziale, tra gli altri, l’aspetto in esame. Si deve a tale intervento legislativo, in primo luogo, un maggiore rigore in tema di conflitto di interessi, in particolare a livello di trasparenza nella gestione. In capo all’amministratore grava un obbligo di informazione particolarmente pregnante, dovendo lo stesso comunicare qualsivoglia interesse all’esito di un’operazione, indipendentemente dal fatto che possa ritenersi conflittuale con quello della compagine sociale.
Un secondo intervento ha visto attenuarsi la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione sprovvisti di deleghe specifiche. Pur rimanendo salva la solidarietà in capo a tutti i componenti, infatti, i non delegati sono chiamati a rispondere senza che la responsabilità sia legata all’obbligo di vigilanza sugli stessi gravante, alla luce della riformulazione del secondo comma dell’art. 2392 c.c. Ad un simile alleggerimento il decreto ha accompagnato un onere che incombe sul destinatario della delega e sul presidente del consiglio di dare periodicamente notizia della gestione generale della società. I tal modo, si è tentato di porre un argine alla diffusa prassi giurisprudenziale che tendeva indiscriminatamente alla condanna solidale della totalità dei membri del Cda e del collegio sindacale. La Cassazione ha, tuttavia, precisato come il dovere di vigilanza, seppur con una limitazione ai fini della configurabilità della responsabilità, continui, in ogni caso, a sussistere (si legga, in questo senso, Cassazione civile, sentenza n. 9384 del 2011), salvo il caso in cui il consigliere, “pur essendosi diligentemente attivato, non abbia potuto in concreto esercitare la predetta vigilanza a causa del comportamento ostativo degli altri componenti del consiglio” (Cassazione civile, sentenza n. 22911 del 2010, nonché Cassazione civile, sentenza n. 11643 del 2010).
Il legislatore del 2003 ha, poi, inteso incidere con riferimento all’esperibilità dell’azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c., apprestando una maggior tutela alla minoranza e ai singoli azionisti. Invero, con il nuovo art. 2393bis c.c. l’azione può esercitarsi da parte di una minoranza qualificata di soci che rappresenti “almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto”. Secondo l’opinione prevalente in dottrina si tratterebbe di un’azione del tutto autonoma, con legittimazione concorrente rispetto a quella della società, la quale deve considerarsi litisconsorte necessaria, aderendo o avversando la domanda dei soci minoritari. La modifica trova giustificazione nell’esperienza concreta: raramente, infatti, la maggioranza dei soci, a cui si deve la nomina degli amministratori nonché la fissazione degli obiettivi da perseguire, provvedeva ad adire il giudice per il loro operato.
Resta, in ogni caso, salva la possibilità di esperimento della tradizionale azione sociale di responsabilità ex art. 2393 c.c. sopra richiamata, per mezzo della quale, in seguito ad un’apposita delibera assembleare, è possibile avanzare la pretesa sociale del risarcimento del danno che i comportamenti inadempienti dei soggetti apicali in questione abbiano provocato al patrimonio societario. A ben vedere, l’interpretazione giurisprudenziale ha chiarito come il requisito della preventiva deliberazione dell’assemblea rappresenti sì una condizione imprescindibile dell’azione, ma non al tempo stesso un presupposto processuale, dovendosi con ciò intendere la sufficienza della relativa sussistenza al momento della decisione e non anche della proposizione (Cassazione civile, sentenza n. 18939 del 2007). La Suprema Corte ha, per di più, osservato come la natura dell’azione sia da ritenersi contrattuale e presupponga un “illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti dalla legge e dall’atto costitutivo”.
Più controversa appare la qualificazione della natura dell’azione promossa dai creditori sociali ex art. 2394, ai sensi del quale è consentito a tali soggetti di agire qualora il patrimonio sociale risulti inidoneo a soddisfare la pretesa creditoria. Autorevoli commentatori, affermandone la natura contrattuale, hanno posto l’accento sul generale dovere scaturente dal contratto di protezione dei terzi ricavabile dall’interpretazione dell’art. 1173 c.c.; altra e maggioritaria dottrina, così come la giurisprudenza prevalente, la ritiene un’autonoma azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c, ove individuare la “lesione del credito” quale condotta illecita, (si veda, a titolo meramente esemplificativo, Cassazione civile, sentenza n. 15955 del 2012).
Si registrano tesi discordanti anche con riferimento alla ratio della norma. Taluno ha rilevato come l’azione miri ad una reintegrazione del patrimonio sociale limitatamente ai crediti rimasti insoddisfatti, altri hanno messo in luce come la reintegrazione riguardi esclusivamente il patrimonio del singolo creditore sociale, il quale si vedrebbe corrisposta una prestazione, da parte dell’amministratore, che la società non è più in grado di garantire (quest’ultimo assunto è condiviso da una risalente giurisprudenza, Cassazione civile, sentenza n. 10488 del 1998). Ai fini della configurabilità di una forma di responsabilità in quest’ottica risulta necessario provare il concorso di più presupposti: un pregiudizio patrimoniale patito dai creditori, una condotta degli amministratori illegittima e il nesso di causalità tra i due.
In ultima analisi, giova sottolineare come, in caso di fallimento, l’esperimento dell’azione spetti al curatore, in forza degli artt. 42 e 43 della Legge Fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), sia a tutela dei singoli creditori sociali sia della società. L’azione, in tale particolare circostanza, può considerarsi “unitaria e inscindibile”, tanto da indurre parte della dottrina a definirla “ibrida”, alla luce della finalità di reintegrazione del patrimonio da riferirsi congiuntamente a soci e creditori.