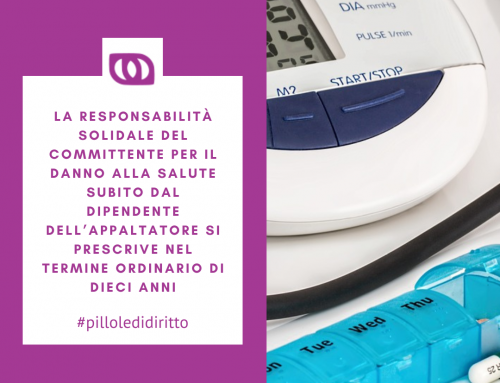Con la recente pronuncia n. 27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite della Suprema di Corte di Cassazione si sono espresse con riferimento ad una questione considerata di massima importanza: l’esatta interpretazione da attribuire al requisito della specificità dei motivi d’appello, in seguito all’intervento legislativo di cui alla Legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del Decreto Legge n. 83 del 2012.
Va preliminarmente rilevato come con la predetta modifica normativa, il Legislatore abbia provveduto a riformare la disciplina codicistica del giudizio d’appello, modificando, in particolare, gli artt. 342 e 434 c.p.c. e introducendo espressamente la possibilità per il giudice di addivenire ad una pronuncia di inammissibilità, ove l’atto di appello sia privo dell’”indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” ovvero dell’indicazione “delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. L’interpretazione di simili requisiti ad opera della stessa Corte di Cassazione è risultata, nelle prime pronunce seguenti l’approvazione della legge in questione, non uniforme, anche (e soprattutto) in virtù dell’abrogazione del riferimento “all’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi specifici di impugnazione”.
Nel tentativo di individuare con precisione il contenuto minimo dell’atto d’appello, ai fini dell’ammissibilità dello stesso, un primo orientamento (Cassazione, sezione Lavoro, sentenza n. 2143 del 2015) ha messo in luce la necessità che l’atto in questione rispetti specifici oneri formali posti in capo all’appellante, i quali consentano di “individuare agevolmente” il quantum appellatum, nonché di circoscrivere l’ambito del giudizio agli specifici capi della sentenza di primo grado e “ai passaggi argomentativi che li sorreggono”. La parte, sulla base della stessa sentenza, dovrebbe formulare le proprie doglianze per mezzo di un “percorso logico alternativo a quello adottato dal primo Giudice”, chiarendo altresì in che modo tale percorso sia idoneo “a determinare le modifiche alla statuizione censurata”. Per mezzo della sentenza n. 17712 del 7 settembre 2016, invero, la stessa Corte è pervenuta ad una conclusione parzialmente differente, ritenendo necessaria la proposizione da parte dell’appellante di una precisa soluzione della controversia alternativa rispetto a quella adottata in primo grado.
Investite della questione, le Sezioni Unite hanno tendenzialmente confermato il primo degli approcci citati. In particolare, la principale esigenza sottostante la riforma del 2012 consterebbe, a dire del Supremo Collegio, nella necessaria chiarezza dell’enucleazione dei punti della sentenza contestata, nonché delle relative doglianze. In altri termini, un atto di appello correttamente redatto dovrebbe contenere da un lato una parte volitiva e dall’altro una componente argomentativa “che confuti o contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”. Tuttavia, la Corte ha negato che l’individuazione del percorso logico alternativo sopra richiamato debba tradursi, come contrariamente affermato nella pronuncia n. 17712, “in un progetto alternativo di sentenza”, risultando per converso sufficiente che il giudice di appello sia posto in condizione di comprendere adeguatamente le censure proposte. Va da sé che la maggiore o la minore ampiezza della formulazione della domanda si presta a rappresentare, come rilevato dal Supremo giudice, una diretta conseguenza del livello di dettaglio della motivazione in primo grado. Allo stesso tempo, la sentenza in commento ha escluso la necessità di “particolari forme sacramentali o comunque vincolate”; nonostante la riforma, il Legislatore non avrebbe, in alcun modo, inteso trasformare l’appello in un mezzo di impugnazione a critica vincolata, mantenendo lo stesso, seppur con il filtro di inammissibilità predetto, i caratteri di un giudizio di merito. Giungendo a differenti conclusioni, continua la Corte, si rischierebbe di alterare i tratti di tale gravame, convertendolo in “una sorta di anticipato ricorso per Cassazione”.
Giova, da ultimo, segnalare il passaggio argomentativo conclusivo offerto dalle Sezioni Unite, le quali, esprimendosi con riferimento ai principi generali di ordine processuale, hanno messo in luce come le norme di procedura vadano interpretate nel senso di favorire, ove possibile, una pronuncia nel merito da parte del giudice, dovendosi, quindi, ritenere gli eventuali “esiti abortivi” del processo come residuali. Tale assunto si porrebbe, a dire del Collegio, in continuità con quanto precedentemente affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per la quale, in materia processuale, “le limitazioni all’accesso ad un giudice” sono consentite esclusivamente allorquando previste in maniera espressa da una disposizione legislativa e comportano, per di più, l’applicazione di un principio di proporzionalità “tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito” (in questo senso, si legga, tra le altre, la sentenza CEDU del 24 febbraio 2009).