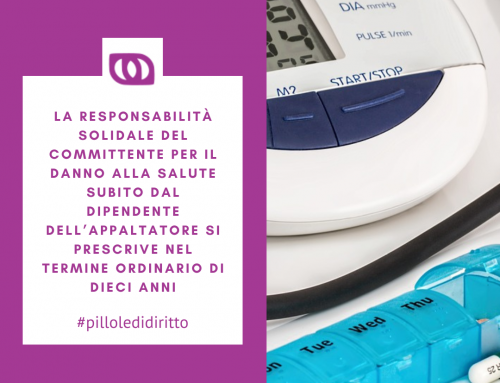Con la recente ordinanza n. 3977 del 19 febbraio 2018, la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento al tema del c.d. “straining”, da intendersi quale forma di mobbing a carattere attenuato.
Nel caso di specie, una dipendente scolastica, dichiarata inidonea all’insegnamento e successivamente assegnata alla segreteria della scuola, era stata vittima di atteggiamenti a carattere pressoché vessatorio da parte del dirigente scolastico, in seguito ad una situazione di tensione tra i due, sorta in seguito ai rilievi mossi dalla stessa in merito alla necessità di implementare il personale per lo svolgimento dei servizi amministrativi. Il preside, in particolare, aveva provveduto dapprima a sottrarre alla dipendente taluni strumenti di lavoro e ad affidarle mansioni di tipo didattico (nonostante la richiamata inidoneità della stessa), per poi privarla integralmente di qualsivoglia mansione e relegandola ad uno stato di inattività.
Esprimendosi sulla questione, la Suprema Corte, nell’affermare, come detto, che lo straining costituisce una “forma attenuata di mobbing”, ha affermato come alle condotte a tale nozione riconducibili possa conseguire una condanna al risarcimento ai sensi dell’art. 2087 del Codice civile, ove sia dimostrato un effettivo pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore. Trattasi di un’interpretazione della norma (che, occorre precisare, impone al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”) di tipo estensivo, finalizzata a garantire il rispetto – costituzionalmente prescritto (si vedano, in questo senso, art. 32, art. 41 e art. 2 Cost.) – di beni essenziali e primari quali “il diritto alla salute, la dignità umana e i diritti inviolabili della persona”. Invero, sulla base dell’ordinanza in commento, non dovrebbe intendersi la tutela antinfortunistica offerta dall’art. 2087 c.c. in senso stretto, ben potendo, per converso, configurarsi in capo al datore un obbligo di garantire la sicurezza generale dell’ambiente di lavoro e, con ciò, lo stesso è chiamato altresì ad impedire in toto che all’interno di tale ambiente “si possano verificare situazioni idonee a mettere in pericolo la salute e la dignità della persona”. Ciò detto, il titolare deve ritenersi chiamato a rispondere ogniqualvolta sia riscontrabile un comportamento quanto meno colposo cui può eziologicamente ricondursi l’evento dannoso. Le azioni ostili cui era risultata vittima la dipendente, tra cui, come precedentemente richiamato, la “privazione ingiustificata degli strumenti di lavoro”, l’assegnazione di mansioni non compatibili con il suo stato di salute e la riduzione “in una condizione umiliante” di totale inoperosità, per quanto sprovviste del carattere sistematico e reiterato idoneo a configurare la fattispecie di mobbing, potevano senz’altro integrare lo straining.
La predetta pronuncia assume una significativa rilevanza, poiché si inserisce nel filone giurisprudenziale atto a riconoscere tale forma di tutela che potrebbe oramai ritenersi consolidata in sede di giudizio di legittimità. L’approdo di tale figura nell’ordinamento si deve, in particolare, ad una pronuncia di merito e, nello specifico, alla sentenza del Tribunale di Bergamo del 21 aprile 2005 che, recependo buona parte delle elaborazioni della psicologia del lavoro in tema di situazioni lavorative di conflittualità, ha affermato la necessaria risarcibilità di danni conseguenti ad azioni che, in mancanza di frequenza e, quindi, anche se “poche” e “distanziate nel tempo” ovvero consistenti in un’unica condotta (“come un demansionamento o un trasferimento disagevole”) siano idonee a ledere il dipendente in maniera duratura. Allo stesso Tribunale di Bergamo si deve, peraltro, una prima definizione giurisprudenziale della fattispecie, intesa come “stress forzato sul posto di lavoro”. Ad ogni modo, occorre rilevare come, in ogni caso, seppur in presenza di un onere probatorio che, in virtù di quanto sopra, risulta attenuato rispetto alla gravosità della dimostrazione del mobbing, le azioni censurabili debbano necessariamente ricondursi ad un intento discriminatorio quale scelta precisa e volontaria, ritenendosi per converso non risarcibile una mera situazione di stress dovuta a carichi di lavoro eccessivi.