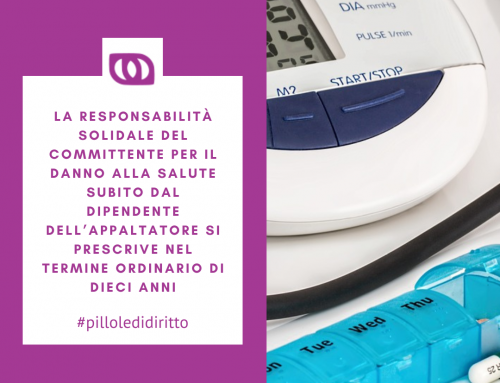La Suprema Corte di Cassazione, per mezzo della recente sentenza n. 24073 del 13 ottobre 2017, si è nuovamente pronunciata con riferimento alle regole di ripartizione dell’onere probatorio in caso di responsabilità medica, nonché sul tema del nesso di causalità.
Nel caso di specie, una struttura ospedaliera ricorreva avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria che aveva riconosciuto un risarcimento per inadempimento contrattuale ad una paziente. In particolare, la stessa era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di asportazione totale di un rene, resosi necessario in virtù di una diagnosi di neoplasia, risultante da un’ecografia e da una TAC. Invero, da un esame approfondito effettuato direttamente sul rene asportato, si era evidenziata la presenza di una patologia di tipo infettivo che, se diagnosticata tempestivamente per mezzo di una biopsia estemporanea, avrebbe escluso l’esigenza di un simile intervento invasivo, risultando per converso sufficiente una nefrectomia solo parziale. Dalle censure mosse dall’azienda sanitaria emergeva la contestazione relativa al nesso di causalità che, stante la difficoltà di asserire con certezza che l’effettuazione dell’esame bioptico avrebbe comportato una corretta diagnosi ed “essendo comunque estremamente difficoltoso distinguere l’infezione dal carcinoma”, avrebbe dovuto ritenersi non sussistente.
La Corte ha avuto modo, al riguardo, di ribadire come la questione possa inquadrarsi nell’ambito del criterio della prevedibilità oggettiva, in base al quale effettuare una verifica, basata su regole statistiche ovvero leggi scientifiche, dell’idoneità o meno “del comportamento omissivo ad impedire l’evento dannoso”, dovendosi escludere la sussistenza del nesso eziologico limitatamente al caso in cui il comportamento dovuto “non sarebbe riuscito in alcun modo ad evitare l’evento”. Nella controversia in oggetto, pur nell’incertezza relativa all’effettiva possibilità di riscontrare correttamente l’infezione in seguito a biopsia, a venire in rilevo sarebbe stata, in ogni caso, l’astratta idoneità dell’esame “a disvelare la corretta patologia”.
Ai fini del riconoscimento di un risarcimento al paziente, lo stesso deve ritenersi chiamato a dimostrare l’esistenza di un contratto con la struttura sanitaria, l’insorgenza o l’aggravamento di una patologia, nonché ad allegare l’inadempimento del debitore “astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato”. Spetta, per converso, all’azienda ospedaliera provare l’assenza di tale inadempimento, ovvero la relativa irrilevanza eziologica (si leggano, in questo senso, anche Cassazione, sentenza n. 577 del 2008, sentenza n. 27855 del 2013).
Una simile ripartizione dell’onere della prova può direttamente ricondursi alla qualificazione, operata dall’assai recente approvazione della Legge 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli–Bianco), della natura contrattuale della responsabilità delle strutture sanitarie. Recependo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, l’intervento normativo in questione ha “positivizzato” tale tendenza che si presta a fornire maggiori garanzie al paziente danneggiato, alla luce del sopra citato alleggerimento dell’onere probatorio, nonché del più ampio termine di prescrizione (10 anni) rispetto al regime di responsabilità aquiliana ex art. 2043 (5 anni). La suddetta qualificazione è riferibile ad uno specifico rapporto contrattuale atipico, il c.d. “contratto di spedalità”, con il quale la struttura, sia pubblica che privata, si obbliga a fornire al paziente una serie complessa di prestazioni di assistenza sanitaria.
Più controversa appare la definizione della responsabilità del singolo esercente la professione che ha suscitato, negli anni, innumerevoli contrasti interpretativi. Intervenendo anche con riferimento a tale aspetto, il legislatore ha provveduto a superare, con la L. 24/2017, la prassi giurisprudenziale atta a configurare in capo allo stesso una forma di responsabilità da contatto sociale. Quest’ultima categoria veniva, in particolare, definita come “un rapporto che si instaura tra due soggetti non in virtù di un accordo tra le parti, ma di un obbligo legale oppure come conseguenza di un altro rapporto contrattuale instauratosi tra soggetti diversi rispetto a quelli del contatto” (cfr. Cassazione, sentenza n. 589 del 1999) con ciò comportando l’applicazione del regime di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c.. All’art. 7 della legge Gelli-Bianco è prescritto che il medico sia chiamato a rispondere sulla base dell’art. 2043 c.c., “salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale con il paziente”.
Il legislatore parrebbe aver inteso, cristallizzando da un lato l’orientamento giurisprudenziale prevalente con riferimento alla struttura, porre in una situazione di maggiore equilibrio le esigenze di tutela del paziente e di limitazione dei contenziosi, nonché arginare la pratica della c.d. “medicina difensiva”, per mezzo della quale il medico sia portato all’adozione di eccessive cautele al fine di non incorrere in richieste risarcitorie.